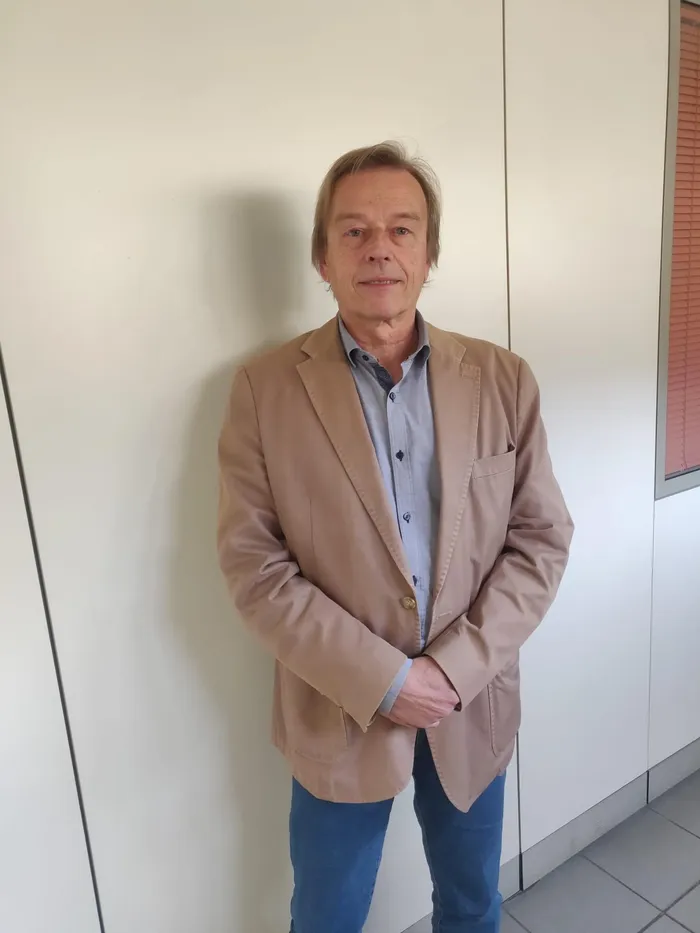Intervista a Roberto Merli: «Ponte della tangenziale, suicidi ridotti dell’80%»
«Nel Biellese tassi più alti come in tutte le province dell’arco alpino. Ma il clima non c’entra»
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno nel mondo oltre 700mila persone si tolgono la vita. Una ogni quaranta secondi. In Italia i morti per suicidio sono circa 4mila all’anno, e Biella è una delle città con i tassi più alti d’Italia. Chi ha dedicato al tema gran parte della propria carriera professionale è Roberto Merli, già direttore di Psichiatria dell’Asl Biella, che recentemente ha pubblicato un articolo con la professoressa Alessandra Costanza, ricercatrice all’università di Ginevra, sulla rivista scientifica internazionale “Preventive Medicine Reports” sui risultati che la messa in sicurezza di ponti e di altri siti a rischio ha sulla prevenzione del suicidio da precipitazione. Il ponte della tangenziale di Biella nel 2019 ha subito un profondo restyling, con reti di protezione, videosorveglianza e allarmi a infrarossi perimetrali dotati di sirene.
Dottor Merli, quanti suicidi e tentativi di suicidio sono stati evitati da quando sul ponte sono state posizionate telecamere, cancelli e barriere di protezione?
In base ai dati in mio possesso, nei quattro anni successivi all’installazione di queste misure protettive c’è stata una riduzione di quasi l’80 per cento dei suicidi dal ponte in esame rispetto allo stesso periodo precedente alla messa in sicurezza. Questo conferma i risultati di altri studi internazionali che testimoniano come la limitazione dell’accesso ai metodi di suicidio sia la più efficace forma di prevenzione. Ci sono esperienze che parlano addirittura di un 100% di successo, in termini di riduzione di suicidi da precipitazione nei siti a rischio. Tornando al caso di Biella, nel confronto tra i due periodi, ho inoltre rilevato una riduzione del 50% dei tentativi di suicidio dallo stesso luogo. La mia ipotesi è che essendoci stata minor comunicazione mediatica su eventi suicidari si è ridotto il fenomeno imitativo, il cosiddetto “effetto Werther”.il quale viene contrastato dal cosiddetto “effetto Papageno”.
Che cos’è l’effetto Papageno?
È l’effetto di prevenzione del suicidio dovuto a una migliore comunicazione mediatica sui comportamenti suicidari. Come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ai giornalisti, a partire dal 2008, su come trattare la materia per il pubblico, evitando modalità che inducano comportamenti imitativi e fornendo al contempo informazioni utili su come cercare aiutano quando si vivono periodi di crisi accompagnati da pensieri di suicidio. I media rappresentano quindi un prezioso alleato dei professionisti sanitari nel lavoro di prevenzione e un efficace strumento per aiutare chi si trova in difficoltà a trovare il supporto necessario.
Quanto è importante realizzare sistemi di sicurezza nei siti a rischio per disincentivare i suicidi?
È fondamentale. Più le varie tipologie di barriere si avvicinano ai criteri architettonici consigliati dai tecnici in base ai risultati ottenuti, maggiore è l’efficacia preventiva verso la precipitazione: non si dimentichi che chi si lancia dai ponti in tre casi su quattro ha un’età inferiore ai 45 anni, dunque possiede un atletismo che gli consente di superare protezioni superficiali o non adeguate.
È vero che chi tenta un suicidio da un ponte e trova un ostacolo cercherà poi di replicare il gesto in un altro posto?
È una convenzione errata. Lo spostamento da un sito a rischio a un altro, dopo che nel primo si sono trovati degli impedimenti, è un fatto rarissimo, attestato da diversi studi. La scelta di un dato luogo è spesso legata a motivi molto personali (perché è famoso, perché ricorda qualcosa, perché chi tenta il suicidio sa che da lì non ci sono stati sopravvissuti): molti di quelli che hanno tentato di uccidersi, ma sono poi sopravvissuti, hanno spiegato che non avrebbero mai scelto un altro luogo. Ribadisco il concetto che incontrare degli ostacoli efficaci può impedire il suicidio: le crisi suicidarie acute non durano mediamente a lungo (parliamo di ore o minuti) e le persone in crisi sono di condizionate da un pensiero monotematico rigido che, nella maggior parte dei casi, impedisce loro di elaborare soluzioni alternative al metodo prescelto, come spostarsi in un altro posto. Le barriere sui punti, soprattutto, hanno proprio lo scopo di ritardare l’azione e favorire la cessazione della crisi acuta o anche l’intervento di soccorso prestato dalle forze dell’ordine o da qualche persona di passaggio. Importante che tutti sappiano che la persona in crisi attende sempre un intervento salvifico dall’esterno, anche se sembra non volerlo. Cercare di stabilire un contatto e offrire attenzione e ascolto può salvare una vita.
Le statistiche dicono che il tasso di mortalità per suicidi nel Biellese è tra i più alti d’Italia: da dove nasce questo “male di vivere” che sembra tipico del nostro territorio?
La nostra provincia, come quasi tutte quelle dell’arco alpino, fa parte di un’area geografica con elevati tassi di suicidio: vedi Sondrio, Cuneo, Aosta, Bolzano, Trieste. A determinare i tassi concorrono molteplici fattori. Quello più indicativo del rischio di suicidio è avere effettuato un tentativo precedente. Ad esempio chi ha tentato di suicidarsi in passato corre il rischio di ripetere il gesto. Alcuni fattori di rischio sono individuali. Come il sesso, la presenza di malattie, traumi e abusi fisici, psicologici e sessuali subiti nell’infanzia, l’età, gli stili e la qualità di vita, ad esempio il fatto di dover fare da caregiver per un coniuge gravemente malato. Altri fattori sono legati a questioni culturali, ambientali e socio-demografiche. Altri ancora sono collegati all’offerta e all’efficienza dei servizi di assistenza di salute mentale sul territorio. Ci sono sostanziali differenze tra grandi città e piccoli capoluoghi di provincia, tra aree industrializzate e aree rurali. Nelle grandi città le persone hanno maggiori offerte e meno difficoltà a cercare aiuto da uno psichiatra o uno psicologo. Nei piccoli centri, invece, la paura di essere additati e considerati (erroneamente) come persona inaffidabile o mentalmente disturbata, solo per la frequentazione di un centro di salute mentale o di professionisti del settore, è più presente per motivi intuibili. Stigma è il termine che definisce questa paura di essere riconosciuti e scoperti e agisce come un gravissimo ostacolo nella ricerca di un aiuto appropriato.
Quando ha portato esempi di zone con elevati tassi suicidari, ha fatto riferimento a province del Nord Italia. Come mai al Sud sono più bassi?
Esistono alcune differenze tra le province del Nord e del Sud. Il Sud, pur avendo un’economia più svantaggiata e una percentuale di disoccupazione più elevata, ha migliori condizioni climatiche che favoriscono attività fuori casa e facilitano i contatti sociali. E la capacità di stabilire e mantenere contatti sociali costituisce uno dei maggiori fattori protettivi. A proposito di fattori protettivi, un altro è rappresentato dalla struttura famigliare e dalla rete di relazione parentale e sociale, che sembrano essere più presenti al Sud che al Nord. Chiaramente si parla sempre di tendenze, perché ci sono anche province del Sud o la Sardegna con tassi suicidari elevati. Esiste poi un terzo aspetto maggiormente frequente al Nord, che riguarda il numero di consumatori a rischio abuso di sostanze alcoliche. L’alcol è infatti un importante fattore di rischio. Induce minore capacità di giudizio e di riflessione, e una maggiore impulsività, che impedisce di riflettere e meditare adeguatamente, dunque di prendere tempo: come già detto, la crisi suicidaria è un fenomeno fluttuante, che ha picchi temporanei, da qualche minuto a qualche ora. Se la persona non riesce ad accedere a un metodo di suicidio letale, ci sono molte possibilità che la crisi termini e possa essere aiutata. Sotto l’effetto di alcol si riduce inoltre l’angoscia della morte per suicidio e il dolore che potrebbe provocare, aspetti che potrebbero facilitare un comportamento suicidario.
Anche il clima influisce sull’aumento dei suicidi? È vero che nelle nazioni del Nord Europa la percentuale di suicidi è più alta?
No, è sbagliato. Lo dicono le statistiche. Un confronto tra gli Stati europei del 2015 vede al primo posto per tassi di suicidio la Lituania e al secondo posto la Slovenia. Anche l’Austria e la Svizzera hanno tassi elevati rispetto all’Italia. Prima della caduta dell’Unione Sovietica il Paese dell’Europa con i tassi più elevati era l’Ungheria, una nazione pianeggiante. Solo al 13° posto compaiono Paesi del Nord come Finlandia e Islanda e al 14° Svezia e Norvegia. La credenza che nei luoghi con temperature fredde vi sia un alto tasso di suicidi è un errore. Ma sempre per quanto riguarda gli effetti del clima, ricerche internazionali hanno dimostrato che esiste un picco di suicidi ad aprile e all’inizio dell’estate e una discesa del picco in inverno: sembra possa essere correlato alla luce solare che influenza un neurotrasmettitore, anche se non esiste ancora nulla di scientificamente definitivo. Altri dati certi, sempre basti su studi internazionali, ci dicono invece che il giorno più a rischio è il lunedì. Mentre non è vero che durante i giorni di festa vi sia un aumento di suicidi.
Prima ha parlato di fattori di rischio. Quali sono invece i fattori protettivi?
Come spiegavo nelle differenze tra Nord e Sud, un fattore protettivo è rappresentato dalla coesione sociale e dalle relazioni sociali. Poi al primo posto la limitazione nell’accesso a metodi letali, come nel caso dei ponti l’uso di barriere o reti. Tra i fattori protettivi più importanti c’è anche la capacità individuale di saper riconoscere un problema e cercare aiuto. Anche affrontare e risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza sembra essere un fattore protettivo. Fattori protettivi sono anche le convinzioni religiosi o culturali: sempre le statistiche dicono che chi si suicida di più sono gli atei. Un altro fattore protettivo è la presenza di una famiglia, di figli, di affetti e legami profondi.
Esistono dei campanelli d’allarme a cui un parente o un amico devono prestare attenzione?
I campanelli d’allarme sono comportamenti osservabili dall’esterno, e chiunque li può notare. Sono da monitorare, per esempio, quelle persone che parlano di morte o suicidio in modo esplicito. Che sono solite ripetere frasi come “magari fossi morto” o “a che serve vivere”. Che si isolano dalla famiglia e dagli amici. Che dicono di sentirsi un peso per gli altri. Che perdono interesse per il lavoro, le passioni, le attività che svolgono abitualmente. Che esprimono un senso di esclusione o di perdita di appartenenza alle proprie reti sociali. Che si disfano di oggetti personali cari, che fanno testamento. Che mostrano sovente stati di ansia, agitazione, insonnia, sbalzi di umore. Un forte campanello d’allarme è rappresentato da improvvisi miglioramenti dell’umore dopo un periodo di depressione. Da fuori potrebbe sembrare che la persona abbia ritrovato tranquillità e stabilità, in realtà può essere una calma apparente che precede la tempesta: la persona è calma perché ha superato l’ambivalenza tipica della fase di turbolenza (mi uccido o non mi uccido?) e ha deciso di farla finita, immaginando nella morte la risoluzione ai propri problemi.
Quanti sono invece i casi in cui non vi sono avvisaglie e diventa quindi difficile agire in via preventiva?
Secondo le ricerche internazionali, circa la metà delle persone che si sono suicidate ha contattato il proprio medico di famiglia nei 3 mesi precedenti. Le persone mandano spesso dei segnali di aiuto, che diventano significativi solo se durano nel tempo e che spesso possono essere di difficile interpretazione. Non essendo collegato direttamente a una condizione di malattia psichiatrica, il suicidio rischia di non essere valutato correttamente, se si cerca solo una diagnosi medica. I sentimenti che può esprimere un soggetto suicidario possono non avere a che fare solo con la depressione. Parlo di vissuti di vergogna, umiliazione, demoralizzazione, disperazione, senso di intrappolamento in situazioni di vita che non sembrano modificabili, dolore mentale insopportabile. Queste sono tutte sensazioni presenti in persone a rischio di suicidio, che vanno oltre una diagnosi meramente clinica, ma a cui un medico dovrebbe prestare estrema attenzione.
Non sono poche le persone che tentano un suicidio, ma poi sopravvivono. Quale tipo di percorso clinico e psichiatrico devono poi seguire?
Alcuni sopravvissuti a una precipitazione hanno raccontato che subito dopo il salto hanno avuto un improvviso cambiamento, capendo che in realtà non volevano morire. È il cosiddetto “risveglio”. Questa condizione mette in evidenza un aspetto fondamentale della crisi suicidaria, che può essere di aiuto per gli interventi di prevenzione: ossia l’esistenza dell’ambivalenza, della lotta tra il desiderio di vivere e quello di morire, che è qualcosa sempre presente in tutti. Scontato dire che si occupa di prevenzione del suicidio deve assolutamente sostenere il desiderio di vivere facendo leva su tutte le risorse a propria disposizione. Gli studi internazionali hanno consentito di stilare una sorta di piano di sicurezza per i pazienti a rischio o che hanno tentato il suicidio e sono sopravvissuti. Si tratta di piani che spiegano cosa fare nel momento in cui dovesse ripresentarsi una crisi suicidaria. Cercando di eliminare il pensiero del suicidio e utilizzando le risorse di protezione, come prendere contatti con famigliari e amici; evitare l’isolamento personale e sociale; contattare dei professionisti; rivolgersi ai pronto soccorso degli ospedali aperti 24 ore al giorno per trovare una forma di assistenza nella fase più acuta. Poi è opportuno che la persona venga monitorata nel tempo, dato che la crisi suicidaria è fluttuante: a volte appare e scompare naturalmente, altre è necessario venga eliminata con un supporto psichiatrico e terapeutico. In ultima analisi, è fondamentale potenziare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA